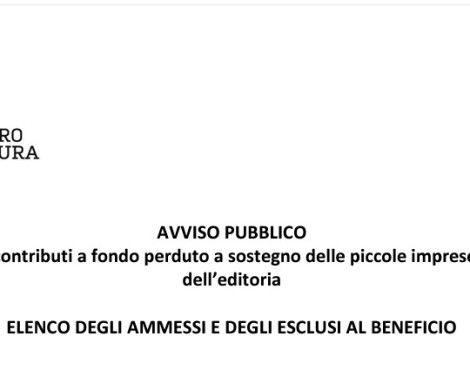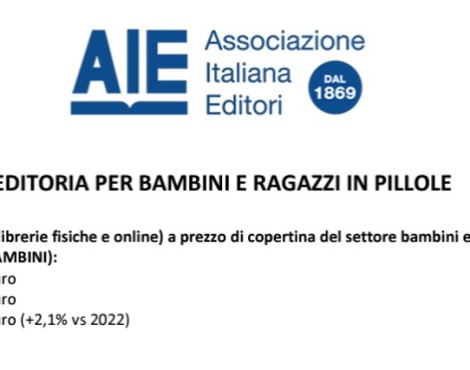Pubblichiamo l’intervento che Flavia Piccoli Nardelli ha tenuto lo scorso 27 maggio a Pavia alla tavola rotonda “Oltre l’Accademia. Dottorato in storia e opportunità professionali” organizzato dal Sissco:
Vi sono grata dell’invito a partecipare a questa tavola rotonda, particolarmente interessante per chi, da un lato, è stata sempre vicina, per formazione e per impegno lavorativo, agli studi storici; da un altro lato, si trova ad avere temporaneamente la responsabilità non solo dell’azione legislativa come parlamentare ma anche di una visione complessiva e strategica del mondo della formazione e della ricerca come Presidente della Commissione parlamentare di merito.
Mi è stato e mi sarà dunque molto utile ascoltare i punti di vista degli “operatori” del settore e raccogliere i loro suggerimenti in vista di interventi normativi che in molti casi sembrano davvero urgenti e indispensabili.
Sono nodi che bloccano lo sviluppo culturale ed anche economico del nostro Paese.
Mi sembra particolarmente interessante – e do atto alla comunità degli storici di aver maturato con l’organizzazione di questi seminari periodici una lunga e interessante tradizione in questo ambito – che a questi seminari periodici siano presenti come protagonisti anche i dottorandi o i neo-dottori di ricerca in discipline storiche.
Il contributo che possono dare i dottorandi che hanno scelto di seguire la passione della ricerca in questo percorso specifico di alta formazione è assolutamente fondamentale per comprendere a fondo i problemi, visti da chi li vive in prima persona, e per affrontare con freschezza innovativa le possibili vie di soluzione. Sono quindi riconoscente a loro e a tutti voi per l’opportunità che mi avete offerto di ascoltarvi su un aspetto fondamentale del futuro del nostro Paese.
Lasciatemi innanzitutto inquadrare brevemente la storia del dottorato di ricerca in Italia, per me stessa, prima che per voi.
Istituito nel 1980 con un notevole ritardo rispetto a molti altri Paesi, ritardo che forse ancora oggi in parte scontiamo in termini di approfondimento e di strategia, il dottorato di ricerca era nato “come titolo accademico valutabile unicamente nell’ambito della ricerca scientifica” ed era destinato “all’approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica” mediante lo “svolgimento di attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Università o presso Università”.
Il passaggio dal vecchio modello delle borse di studio individuali e dell’assistentato volontario al nuovo modello dei “corsi di dottorato di ricerca” fu abbastanza lento e non indolore, soprattutto nelle discipline umanistiche per la particolare tipologia delle attività di ricerca che vi si conducono. Ma il modello finì con il mettere radici, favorendo anche, occorre riconoscerlo, l’internazionalizzazione del nostro sistema di alta formazione.
Diciotto anni dopo, nel 1998, il dottorato di ricerca viene profondamente riformato sulla scia della spinta verso l’autonomia universitaria indotta dalla legge Ruberti del 1989 – corrispondente peraltro a scelte analoghe presenti in tutta Europa: la “Dichiarazione della Sorbona” è dello stesso anno, il “Processo di Bologna” dell’anno successivo – e verso una società della conoscenza in cui l’alta formazione alla ricerca e tramite la ricerca, risultasse strumento importante per l’esercizio delle alte professionalità in tutti i settori del mondo del lavoro.

Ecco allora che “i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione” e le università (o loro consorzi) sono chiamate a disciplinarli in autonomia, con un proprio regolamento che ne stabilisce “le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio”. È inoltre prevista, per la prima volta, “la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria”.
Sono gli anni dell’entusiasmo autonomistico, non privo di risultati importanti, e di una relativa abbondanza di risorse finanziarie e umane. Il regolamento ministeriale del 1999, che stabilisce il quadro entro cui le università esercitano la loro autonomia in tema di dottorato, introduce per la prima volta criteri di idoneità delle sedi (precursori dell’attuale “accreditamento”), stabilisce un numero minimo di 3 dottorandi per ogni anno (di cui almeno la metà beneficiari di borsa di studio) e richiede che “le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un’aggregazione di più settori”.
A testimonianza dell’estensione degli obiettivi e degli sbocchi lavorativi del dottorato, il regolamento introduce per la prima volta la possibilità “di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese”, nel qual caso “il programma di studi può essere concordato tra l’università e i predetti soggetti” al fine di accedere agli incentivi statali introdotti dalla legge finanziaria del 1998 per stimolare l’attività di ricerca nelle piccole e medie imprese. Ovviamente sono termini e situazioni più adatti alla discipline scientifico-tecnologiche che a quelle umanistiche.
Nel piano di sviluppo delle università per il triennio 2001-2003 il Ministero finanzia sperimentalmente 14 “scuole” di dottorato, “finalizzate a costituire poli di riferimento di alta qualificazione, per grandi aree disciplinari o tematiche di ricerca, in ordine alla promozione e al consolidamento di corsi di dottorato di ricerca e di correlate attività di ricerca avanzata, con l’obiettivo di favorire il pieno inserimento di dottori di ricerca nel sistema della ricerca nazionale nelle sue diverse componenti”. È l’esordio di un concetto, quello di scuola di dottorato, che si diffonderà rapidamente nelle università, anche sulla base di indirizzi e incentivi ministeriali.
Ma il vento sta cambiando. Il rallentamento economico iniziato in Italia all’inizio degli anni duemila, poi trasformatosi nella grande crisi globale del 2008-2013, porta a difficoltà sempre maggiori nei finanziamenti pubblici al sistema universitario e ad un rapido ripensamento dell’autonomia universitaria entro un quadro di controlli e valutazioni sempre più stringenti da parte dello Stato centrale.
Matura così la terza fase del dottorato di ricerca, che si concreta con l’articolo 19 della legge Gelmini. Si tratta in realtà di leggere modifiche apportate alla legge del 1998 (forse la più importante è che viene eliminato il vincolo di avere almeno metà dei dottorandi beneficiari di borsa). Ma quello che è chiaramente cambiato e immediatamente percepito dalle università è lo spirito assai meno autonomistico della normativa del dottorato, in concordanza del resto con tutto il mood della legge Gelmini.
Infatti “le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi … nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca” che possono istituirli, “sono disciplinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, …”.
Il decreto previsto dalla legge sarà poi il n. 45 del 2013, a voi tutti ben noto, emanato dal Ministro Profumo. Ciò che era forse implicito nella legge, diventa esplicito nel decreto: cioè il Ministero, in questo come in altri casi, sceglie un modello di dottorato e lo rende praticamente obbligatorio tramite l’adozione di una batteria di indicatori numerici, eguali per tutte le aree disciplinari e per tutti gli atenei, le cui soglie sono da rispettare rigorosamente per ottenere l’accreditamento, cioè in realtà l’autorizzazione ministeriale a svolgere i corsi di dottorato.
Si noti che il decreto stabilisce che “il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca”, provvedendo quindi ad allargarne ulteriormente gli obiettivi formativi. Inoltre un articolo specifico del decreto è ora destinato alle norme riguardanti i dottorati “in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione”. Le scuole di dottorato diventano eventuali modalità di organizzazione e coordinamento dei corsi di dottorato e viene introdotta la famosa norma capestro del minimo di 4 borse per ogni ciclo. Nonostante che i dipartimenti non siano citati (e anzi i collegi dei docenti possono contenere personale degli enti di ricerca), tutta l’organizzazione delle università, portata dalla legge Gelmini verso grandi dipartimenti multidisciplinari, finisce con lo spingere quasi tutti gli atenei a organizzare i corsi di dottorato per dipartimento.
Gli effetti dell’applicazione del DM 45/2013 e delle successive linee guida ministeriali del 2014 sono stati subito evidenti: i corsi di dottorato sono diminuiti, secondo i dati forniti dall’ADI, Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca italiani, da 1557 a 915 (- 42%) in un solo anno accademico; i posti di dottorando da 12.338 a 9.189 (- 26%) nello stesso anno. È vero che le borse di studio rimangono praticamente invariate ad un numero di poco più di 7.000 l’anno, ma occorre considerare che, anche prima del 2013, l’Italia occupava il terzultimo posto in Europa per numero di dottorandi in proporzione alla popolazione, davanti solo alla Spagna e a Malta, con 0,6 dottorandi ogni mille abitanti. Quindi questa posizione non lusinghiera non potrà che essere peggiorata in questi ultimi anni.
Negli ultimi due anni non vi sono stati, mi sembra, interventi di rilievo sul tema del dottorato di ricerca ma non posso non segnalarvi che nello schema di decreto sui criteri della ripartizione del fondo di finanziamento ordinario 2016, inviato qualche giorno fa dal Ministro agli organi competenti per il parere di rito (CUN, CRUI, ANVUR ma non le Commissioni parlamentari), sono presenti quote di finanziamento destinate ai “dottorati innovativi nell’ambito delle finalità del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2017” appena emanato e anche criteri per la ripartizione dei fondi per le borse di dottorato che comprendono il “grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico”. Sono aspetti che possono sembrare marginali ma che meriterebbero un’attenta analisi perché finiscono col fornire implicite indicazioni strategiche alle università e al Paese.

Ho ricordato la storia della normativa sul dottorato solo per condividere con voi la lettura di un percorso di lenta riforma che è durato lustri ma che non si è mai consolidato effettivamente nella realtà universitaria, col risultato di un’incertezza di fondo e di una riproposizione di problemi sempre simili a se stessi e, proprio per questo, difficilmente risolvibili con gli strumenti ordinari disponibili. Mi sembra ad esempio di aver colto alcuni aspetti di questa osservazione nell’interessante contributo di Maria Malatesta e Valentina Cappi pubblicato su “Società e storia” nel 2015, soprattutto negli sconfortati e sinceri commenti raccolti dalle autrici tra gli attuali dottorandi di ricerca in storia.
Altrettanto sconfortato mi è sembrato l’intervento al Convegno SISSCO del settembre scorso da parte del prof. Marco De Nicolò sulla dispersione delle attività formative dei dottorandi. Ma una nota aggiuntiva che ho avuto recentemente per sua cortesia mi sembra colga un punto che mi sento di condividere: “Eclissate le illusioni che il dottorato potesse effettivamente svolgere il ruolo di imbuto nella selezione degli studiosi del prossimo futuro … ci si era avviati su un terreno formativo che, pur non lasciando certezze dal punto di vista dello sviluppo della carriera, raccoglieva discipline coerenti attorno a un progetto credibile”. Mi sentirei anch’io di sollecitare gli atenei, come ha fatto De Nicolò, a “mostrare minore passività nel seguire le sollecitazioni ministeriali, anche a costo di perdere qualche risorsa”. In altre parole, a tornare a rivendicare quell’autonomia di scelte e strategie che devono rimanere connaturate al mondo dell’università e della ricerca a pena di perdere la propria natura. Se si riveleranno necessari nuovi interventi normativi, nel senso della semplificazione dei vincoli e delle regole, il Parlamento potrà certamente dedicarvisi.
Molto interessante, a questo proposito, mi è parsa l’idea avanzata da Malatesta e Cappi di strutture territoriali o regionali di dottorato, che ricreino in qualche modo nel nostro Paese i laboratoires presenti in Francia per la formazione dottorale. Se le risorse attualmente disponibili in Italia non permettono di avviare in tutte le sedi che ne hanno le forze dottorati di ricerca in storia (senza l’attuale dispendio delle discipline), allora effettivamente un’organizzazione di tipo consortile e fortemente territorializzata (senza i pesi burocratici dei consorzi e senza fittizie ripartizioni dei territori fissate a tavolino) potrebbe riavviare un percorso di crescita dello strumento del dottorato di ricerca come innalzamento del livello formativo dell’intera società italiana.
Questo aspetto si collega appunto all’altro argomento del vostro convegno, cioè le opportunità professionali per i dottori di ricerca in storia. Non vi può essere dubbio che, in un periodo di così forte contrazione degli organici universitari, è impensabile che il dottorato di ricerca costituisca il primo gradino della carriera universitaria per tutti. Si pensi solo che, a fronte dei 7.000 nuovi dottorandi ogni anno, i nuovi ricercatori a tempo determinato non hanno superato fino al 2015 i 600 l’anno.
Ora, è certamente auspicabile che il blocco del turnover si allenti presto e che il nostro Paese possa tornare ad investire nell’università e nella ricerca. Una piccola ma significativa inversione di tendenza è già presente nell’ultima legge di stabilità. Ma sarebbe opportuno lavorare affinché la competenza e l’esperienza maturate dai dottori di ricerca – che hanno raggiunti i gradi più alti degli studi, per usare la bella espressione costituzionale, dove per “gradi più alti” si può intendere sia il terzo livello del diploma conseguito, sia anche il maggiore grado di conoscenze e abilità da loro maturato – non vengano malamente disperse o cedute “gratis” ad altri Paesi.
Il nuovo sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti secondari, introdotto dalla legge 107/2015 sulla buona scuola, è in fase di approntamento con la stesura del decreto delegato. Ritornare alla forma concorsuale, su base fortemente disciplinare, per qualunque entrata nel mondo scolastico, abbandonando definitivamente il sistema dell’abilitazione e delle graduatorie, dovrebbe favorire i dottori di ricerca e comunque si dovrà insistere che, una volta esclusi i titoli di servizio, il dottorato di ricerca sia un titolo adeguatamente riconosciuto nel punteggio concorsuale. Da questo punto di vista anche la prevista revisione delle classi di concorso e delle classi di laurea magistrale dovrebbe vedere, se possibile, la costruttiva presenza degli esperti delle varie discipline, quindi la storia nel vostro caso particolare, pur dovendosi tener conto che si confronteranno due esigenze contrapposte: quelle della scuola con le sue necessità di flessibilità, interdisciplinarità, didattica per competenze, quelle dell’università con le sue necessità di specializzazione e ricerca.
Ma non può essere nemmeno trascurato tutto il mondo del lavoro nella pubblica amministrazione o, più in generale, nelle attività culturali sia gestite da enti pubblici che da enti privati. Occorre ritornare a norme di legge mai veramente attuate e prevedere che in determinate posizioni lavorative il dottorato di ricerca sia passaporto praticamente indispensabile, proprio come lo è per la carriera universitaria. Archivi, biblioteche, musei, teatri, fondazioni culturali, ma anche enti territoriali, dovrebbero tenere in attenta considerazione la possibilità di dotarsi di dottori di ricerca in storia per le loro attività culturali. L’innovazione e lo sviluppo culturale, in tutti i campi, hanno bisogno di chi si è formato seriamente alla ricerca e come tale è capace di impersonare innovazione e sviluppo ovunque si trovi a lavorare.
Su questa linea è il concorso straordinario, bandito tre giorni fa in deroga alle norme vigenti sul blocco del turnover, dedicato ai professionisti dei beni culturali per inserire 500 nuovi funzionari nei ranghi dell’amministrazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, da inquadrare nei vari profili professionali: [antropologo (5 posti), archeologo (90 posti), architetto (130 posti), archivista (95 posti), bibliotecario (25 posti), demoantropologo (5 posti), promozione e comunicazione (30 posti), restauratore (80 posti) e storico dell’arte (40 posti)]. Il bando, infatti, prevede quale prerequisito per l’ammissione al concorso il possesso, oltre che della laurea specialistica o laurea magistrale, anche del diploma di dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, in materie attinenti il patrimonio culturale.
Concludo con un ultimo dato statistico, che proviene dal recente documento ministeriale “Strategia italiana per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca”. I ricercatori italiani – intendendo con questa dizione tutti coloro che sono impegnati, nel pubblico o nel privato, in attività di ricerca – sono 118.000, cioè meno della metà di quelli di Francia e Gran Bretagna, meno di un terzo di quelli della Germania. In rapporto alla popolazione l’Italia occupa il penultimo posto in Europa, davanti solo alla Polonia, con meno di 2 ricercatori ogni mille abitanti, a fronte di una media che supera i 3 ricercatori e valori massimi che toccano in Danimarca e Finlandia persino il valore di oltre 7 ricercatori ogni mille abitanti. Le possibilità occupazionali dei dottori di ricerca passano ovviamente anche attraverso un deciso aumento, nel settore pubblico e nel settore privato, di posizioni lavorative di ricerca.
Mi sembra allora importante segnalare che, per quanto riguarda il settore pubblico, l’impegno assunto formalmente dal Governo nel documento strategico è quello di avviare nel medio termine “un programma di reclutamento di ricercatori che consenta di raggiungere livelli prossimi a quelli dei paesi di paragonabili dimensione e tradizioni in Europa” con l’obiettivo che si azzeri in 10 anni “la distanza fra la densità media europea di ricercatori nel settore pubblico per 1000 abitanti (attualmente 1,7) e la densità nello stesso settore in Italia (attualmente 1,1)”. In termini assoluti vuol dire ampliare gli organici di università ed enti pubblici di ricerca di circa 36.000 ricercatori. Un primo impegno, ancora insufficiente, è venuto con l’ultima legge di stabilità che ha stanziato 60 milioni di euro per assumere poco più di 1.000 nuovi ricercatori in tenure-track nelle università e di ruolo negli enti pubblici di ricerca. Una prima tranche di 861 posti è stata già ripartita a febbraio tra gli atenei. Ci impegneremo nel futuro affinché, in coerenza con la strategia nazionale, questo intervento si consolidi e si amplifichi per poter rapidamente raggiungere gli obiettivi previsti.
Chiedo comunque a voi di essere protagonisti di una eventuale ultima modifica nel percorso del dottorato: che deve saper fare chiarezza su quale strada si vuole percorrere; avere come sbocco occupazionale privilegiato la ricerca accademica di eccellenza. In questo caso è necessaria una pianificazione dei bandi e una grande internazionalizzazione dei percorsi formativi, oppure occorre pensare ad un orizzonte oltre l’accademia e allora le scuole di dottorato dovrebbero cominciare ad adeguare la loro offerta formativa al reale mercato del lavoro, con percorsi formativi che, accanto alla capacità di ricerca e ai temi di ricerca, sviluppino anche le skills professionali richieste oggi dal mondo del lavoro e dal mercato culturale.
Una strada può non escludere l’altra, se si arrivasse a modellare percorsi formativi diversi: uno per chi intende provare a rimanere nell’ambito accademico e uno per chi è proiettato a lavorare fuori dall’Accademia.
Dare nozioni di pedagogia, storytelling, nuove tecnologie, nuove tecnologie per la comunicazione, economia della cultura e del territorio, “fundraising” ecc. a tutti non sarebbe comunque una cattiva idea .
Quanto ai temi di ricerca, perché le scuole di dottorato, pur nella loro autonomia, non concordano con istituzioni, aziende, ecc., una serie di temi e di ricerche che corrispondano a reali necessità di ricerca di quelle istituzioni, aziende, territori, ecc.? In questo modo il dottorato potrebbe offrire a studenti che non vogliono o non riescono a rimanere a lavorare in ambito accademico una prima opportunità di occupazione terminato il dottorato.