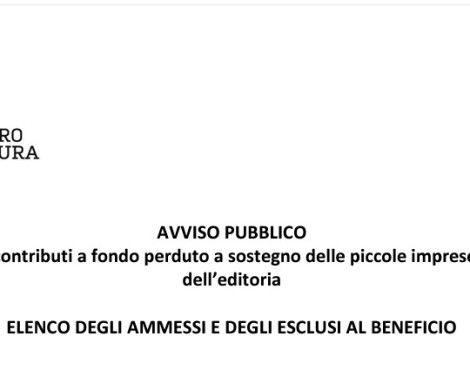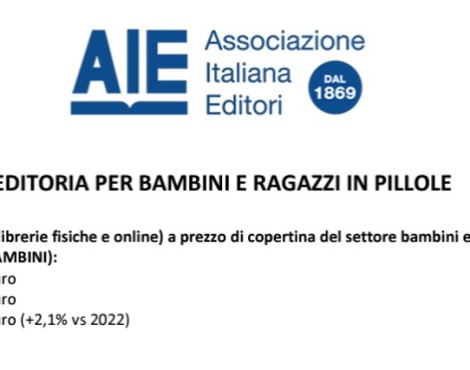Il ministro dell’istruzione Stefania Giannini è stato audito dal parlamento in merito ai programmi del governo sul riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli ex istituti musicali pareggiati, nonché sugli esiti della consultazione pubblica la “Buona Scuola”.
Per il ministro il settore ha necessità di un nuovo modello formativo e l’intenzione e’ di “replicare il modello e metodo seguito per la Buona scuola”. Il ministero ha aperto un confronto con i soggetti del settore, un cantiere intitolato “Chiamata alle Arti”, che ha prodotto un documento in cui sono stati individuati 4 blocchi tematici su cui lavorare: completamento dell’autonomia, governance, internazionalizzazione (“il sistema universitario, salvo alcune punte, mediamente supera di poco il 3% in quanto a presenza di studenti stranieri, qui, invece, siamo al 9% pieno”), assunzione del personale. L’audizione del ministro si è svolta giovedì 25 febbraio scorso in Commissione Cultura del Senato della Repubblica.
Audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania GIANNINI. Il ministro avverte preliminarmente che affronterà innanzitutto il tema del riassetto normativo del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricostruendo analiticamente il quadro normativo di riferimento, con particolare rilievo agli istituti musicali e ai conservatori, tratteggiando poi una gamma di possibili soluzioni delle criticità registrate.
Con riguardo, invece, all’esito della consultazione pubblica la “Buona Scuola”, preannuncia un riepilogo del percorso finora svolto, per poi soffermarsi sui principi e criteri ispiratori del decreto-legge e del disegno di legge delega di imminente adozione.
Venendo allo specifico aspetto del comparto AFAM, fornisce dei dati numerici sulle caratteristiche di tale realtà, precisando che esso si compone di oltre 130 istituzioni pubbliche diffuse, anche se non sempre in maniera omogenea, sull’intero territorio nazionale e articolate in istituti preposti all’educazione musicale oltre a quelli preposti all’educazione artistica, con particolare rilievo, in quest’ultimo caso, all’arte drammatica e alla danza. Sono poi presenti venti accademie di belle arti statali e altre realtà di eccellenza.
Osserva come tali numeri forniscano la misura dell’impegno che il Governo e il Parlamento devono intraprendere per un approccio compiuto a tale settore di strategica valenza culturale.
Espone quindi ulteriori dati sul numero di studenti iscritti alle istituzioni dell’AFAM, specificando che esso ammontava, nell’anno accademico 2013-2014, a circa 85.000 unità: all’interno di tale corpo studentesco, oltre il 10 per cento è formato da studenti stranieri.
Per quanto riguarda invece il corpo docenti, esso risulta pari a 8.000 insegnanti circa, di cui 6.000 a tempo indeterminato e 2.000 a tempo determinato.
In merito alle immissioni in ruolo del personale docente precario, dà conto delle misure adottate sulla base dell’articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede l’assunzione di quota parte dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, sottolineando la necessità di un approccio organico al fenomeno della stabilizzazione degli insegnanti, in questo come in altri comparti educativi.
Ricostruisce quindi il percorso normativo alla base della legge n. 508 del 1999, ricordando che le finalità di tale disciplina consistevano sia nell’allineamento dell’autonomia degli istituti di alta formazione ai parametri propri dell’autonomia universitaria sia ad una equiparazione formale e sostanziale dei titoli di studio rilasciati dal comparto AFAM rispetto ai titoli di studio di altri enti di formazione universitaria.
A distanza di oltre quindici anni dall’entrata in vigore della citata legge n. 508, il bilancio sulla relativa attuazione risulta molto parziale, poiché si è giunti ad una autonomia limitata di tali istituti, anziché ad una effettiva e completa valorizzazione. Sono emerse altresì delle criticità, come, a mero titolo esemplificativo, quelle relative all’assunzione dei docenti e alla programmazione e al riequilibrio dell’offerta didattica, il cui superamento richiede un disegno complessivo sfociato nel documento denominato “Chiamata alle arti” che individua quattro filoni tematici su cui focalizzare i prossimi interventi: il completamento dell’autonomia; la governance degli istituti; l’internazionalizzazione delle medesime istituzioni; infine, il programma di assunzione del personale, anche alla luce del fatto che nel comparto AFAM sono presenti circa 4.000 professori a contratto.
Passa quindi ad esaminare il tema della statizzazione, non ancora avvenuta, degli ex istituti musicali pareggiati (oggi denominati istituti superiori per gli studi musicali) il cui numero ammonta a venti soggetti presenti nel Paese. Al riguardo, rammenta che l’articolo 2, comma 8, lettera e), della legge n. 508 del 1999 disponeva una statizzazione graduale degli istituti, previa istanza dei soggetti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per effetto della mancata attuazione della citata previsione normativa, tali istituti si trovano oggi in una sorta di limbo giuridico, in quanto risultano parificati ai conservatori e quindi rientranti nello spazio comune europeo delle arti musicali; nello stesso tempo, però, i finanziamenti a loro favore derivano dagli enti locali, anziché dallo Stato.afam1
Rimarca quindi la necessità di fornire risposta alla realtà degli ex istituti musicali pareggiati, considerando che essa rappresenta una componente non secondaria della formazione accademica. Fa peraltro presente come attualmente oltre il 90 per cento del bilancio di tutti gli enti del settore AFAM sia utilizzato per coprire le spese per il personale e che tale caratteristica riguarda anche gli ex istituti musicali pareggiati in cui il corpo docente ammonta a circa 617 unità.
Ritiene imprescindibile che l’attuazione completa della legge n. 508, anche nel quadro di una contestuale revisione normativa del settore, sia ancorata al presupposto della non obbligatorietà del percorso di statizzazione e dei vincoli di carattere finanziario esistenti.
Il presidente della Commissione Cultura del Senato interviene incidentalmente per ricordare che la Commissione sta affrontando in queste settimane sia la tematica dell’offerta culturale nel settore musicale, attraverso un apposito affare assegnato di cui la senatrice Elena Ferrara è relatrice, sia il riassetto della normativa sugli ex istituti musicali pareggiati, riguardo al quale sono pendenti alcuni disegni di legge di cui è relatore il senatore Martini.
Il ministro Stefania Giannini, nell’esprimere apprezzamento per tale precisazione, procede poi all’illustrazione degli esiti della consultazione su la “Buona Scuola”, ricordando che gli imminenti provvedimenti legislativi che il Consiglio dei ministri si accinge ad adottare raccolgono il frutto di circa un anno di consultazione e sono finalizzati a passare dalla prospettiva della scuola possibile ad una nuova prospettiva incentrata su “la scuola che vogliamo”.
Tale mutamento prospettico implica l’attivazione di un’effettiva autonomia scolastica, concedendo agli istituti l’organico dell’autonomia, ossia quello adeguato al perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi. Pertanto, il primo punto cardine del decreto-legge di imminente adozione consiste in un piano di assunzioni straordinario volto a stabilizzare le figure di docenti di cui la scuola ha bisogno, valorizzando e potenziando alcune discipline didattiche e ponendo altresì l’accento sull’inclusione e sull’integrazione.
Per questo, ritiene necessario, nell’ambito delle competenze degli studenti, potenziare l’educazione alla cittadinanza attiva, intesa come cultura del rispetto e della sensibilità per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le competenze linguistiche, comprensive non solo di almeno una lingua straniera, ma anche dell’innalzamento qualitativo nell’utilizzo della propria lingua madre. Il raggiungimento di tali obiettivi richiede quindi un corpo docente funzionale all’organico dell’autonomia: pertanto, il piano di assunzioni selezionerà gli insegnanti effettivamente necessari al fabbisogno organico, evitando di portare in cattedra docenti la cui formazione risulta troppo lontana nel tempo o che non hanno insegnato da un numero elevato di anni. Altresì, tra le esigenze didattiche da soddisfare, risulta imprescindibile il potenziamento delle competenze nelle materie letterarie, scientifico-matematiche oltre che nell’ambito artistico, comprensivo dell’educazione sia artistica che musicale il cui insegnamento va impartito già nella scuola primaria.
Il piano di assunzioni sarà poi abbinato alla possibilità, da parte delle scuole e degli studenti, di realizzare il curriculum personalizzato all’interno delle linee guida nazionali.
Un ulteriore intendimento consiste quindi nel rafforzamento della dimensione applicativa e pragmatica rappresentata dall’alternanza scuola-lavoro e dalla formazione tecnica e professionale, valorizzando i relativi percorsi nella scuola secondaria di secondo grado, anche attraverso un incremento del monte ore a disposizione. A tal fine, verranno stanziati 100 milioni di euro per consentire alle scuole di coprire i relativi costi, ponendo anche in essere una semplificazione burocratica per la gestione degli studenti nei centri di formazione e per favorire un incontro scuola-lavoro.
Al riguardo, individua quale modello di seguire quello dei laboratori territoriali rappresentati dalla rete delle imprese e delle università, valorizzando la vocazione territoriale, come accade per gli istituti tecnici superiori.
L’esigenza di abbandonare gli approcci di carattere sporadico, in favore degli interventi programmatici di sistema, richiede inoltre la mappatura del fabbisogno delle scuole e degli studenti, calibrando la stabilizzazione dei docenti sulla base delle diverse esigenze territoriali; altresì, anche il contrasto alla dispersione scolastica implica un approccio sistematico in termini e quantitativi e qualitativi.
La finalità della consultazione sulla “Buona Scuola” risiede altresì nella creazione di una scuola inclusiva e integrativa attraverso l’istituzione, con apposito decreto ministeriale, di una classe di concorso specifica per la formazione di insegnanti preposti all’alfabetizzazione e all’insegnamento della lingua italiana in favore degli alunni stranieri, distinguendo tra quelli nati in Italia e quelli arrivati nel nostro Paese dopo la nascita.
Una politica inclusiva propriamente intesa implica poi uno speciale piano educativo per gli alunni con disabilità, prendendo a modello i centri di eccellenza presenti in Italia per l’insegnamento della lingua dei segni.
Un ulteriore elemento cardine dell’attività riformatrice è rappresentato altresì dal piano di formazione degli insegnanti, che risulta propedeutico sia alla crescita professionale dei docenti sia alla valorizzazione degli istituti scolastici.
Non sfugge poi l’importanza della figura del dirigente scolastico per il quale sarà previsto un sistema di valutazione che consenta di verificare i risultati della sua funzione di garante dei processi scolastici e dei percorsi organizzativi.
Altresì, occorre integrare, come già viene fatto in molte scuole, l’attività didattica frontale con altri metodi sperimentali di insegnamento.
Nel precisare che gli interventi sopra delineati troveranno collocazione nel decreto-legge, evidenzia quindi che, attraverso lo strumento del disegno di legge delega, verranno affrontati ulteriori temi come la revisione degli organismi collegiali delle scuole, il capitolo della disabilità, quello dell’abilitazione, nonché la rivisitazione organica del sistema integrato di istruzione, con particolare riferimento alla fascia di età da 0 a 6 anni, per giungere poi alla predisposizione di un apposito testo unico.
Il presidente della Commissione Cultura del Senato, nel ringraziare il Ministro per l’esaustiva relazione svolta, fa presente che la seduta del Consiglio dei ministri in cui verrà adottato sia il decreto-legge sia il disegno di legge delega dovrebbe tenersi il prossimo martedì 3 marzo e che quindi, successivamente, in una data da concordare, l’audizione del Ministro proseguirà con la formulazione di quesiti e osservazioni da parte dei senatori e con la successiva replica. Auspica, inoltre, che vi siano ulteriori spazi per un’interlocuzione in merito ad altre tematiche come le prospettive di riordino degli enti di ricerca nonché il futuro dell’università.