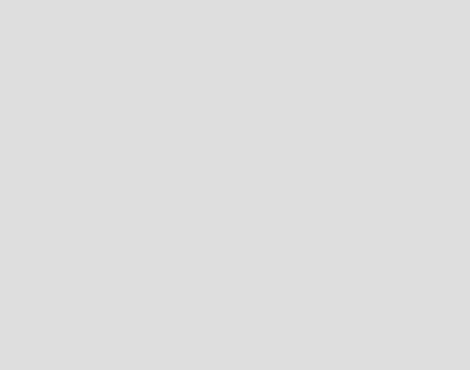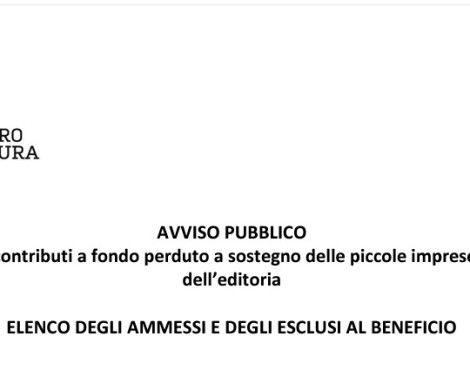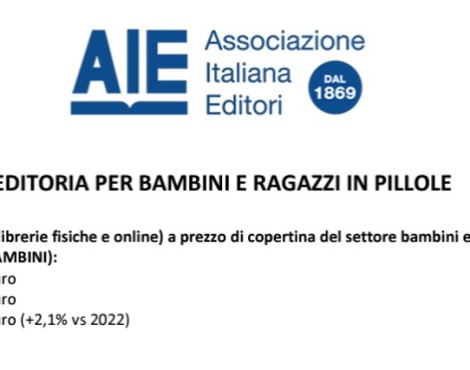Pubblichiamo il testo integrale dell’intervento di Flavia Piccoli Nardelli al convegno CULTURA E BENI COMUNI. TRA TEORIA E PRATICHE, che verte sulle ricadute normative della discussione sui beni comuni: un tema affrontato anche nel dibattito parlamentare su alcune recenti leggi da cui è emerso, quale tratto largamente comune, che i caratteri morfologici, le peculiari tipologie d’utilizzo dei beni d’uso civico sono meritevoli di tutela per la realizzazione di interessi generali, anche perché, dopotutto, la produzione culturale che ne proviene è di per sé un bene comune e, come tale, crea comunità e contribuisce al benessere di tutti.
L’incontro si è tenuto il 4 aprile scorso, presso l’Opificio Romaeruropa. Sono intervenuti: Marco Causi, Dipartimento di Economia Università Roma Tre; Gianni Ruocco, Dipartimento di Scienze Politiche Sapienza Università di Roma; Pierluigi Montalbano, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Sapienza Università di Roma; Giovanni Moro, Responsabile scientifico di Fondaca; Fabio Giglioni, Università La Sapienza – Labsus; Alessandro Splendori, Officine Zero; Flavia Piccoli Nardelli, Presidente uscente della Commissione Cultura della Commissione Cultura della Camera; Francesco Palumpo, Direttore Generale del Turismo Mibact; Pietro Antonio Valentino, Direttore di Economia della cultura.
Di seguito il testo integrale dell’intervento di Flavia Piccoli Nardelli
Ricadute normative della discussione sui beni comuni: riflessioni del Parlamento
Rivolgo un ringraziamento a chi ha organizzato questo incontro così denso e interessante; e ringrazio Marco Causi per avermi invitata.
Non sta a me ripercorrere i punti forti dell’evoluzione del concetto di bene comune. Mi limiterò invece a raccontarvi – pur con la dovuta sintesi – come, in effetti, le difficoltà di questa nozione si siano ripercosse sul lavoro parlamentare.
D’altra parte, l’introduzione tematica al n. 1/2017 di Economia della Cultura parla, da un lato, di “espressione di una sensibilità nuova, di un diverso atteggiamento nei confronti del mondo, delle sue risorse, dei beni e degli esseri che lo abitano …”, ma parla anche di una “certa approssimazione nella definizione concettuale e nell’uso della nozione di bene comune”.
Si parla di “varie strade che ancora non sembrano rincontrarsi”.
L’inclusione dei beni comuni sembra rinviare idee della giustizia come quella di Rawls per cui i beni culturali sono alcuni di quei beni necessari per poter individuare e perseguire l’idea di buona vita del singolo.
E’ noto che, se si guarda all’aspetto statico della titolarità di un bene, i beni sono privati o sono pubblici. Le scienze, sia quella giuridica sia quella economica, non conoscono un tertium genus.
D’altra parte, secondo il codice civile, una cosa è di proprietà privata oppure pubblica; e nelle curve di domanda e offerta che usano gli economisti, una risorsa materiale è di un soggetto determinato, sia esso pubblico o privato.
L’unica deroga che conosciamo a questo assetto è quella degli usi civici, vale a dire la signoria diffusa di una comunità su un bene, tale per cui si può raccogliere il frutto di quel bene: gestire le foreste e i pascoli, raccogliere la legna, manutenere il territorio e così via. [Si tratta di istituti giuridici antichi, frutto di contaminazione tra elementi del diritto comune (in gran parte di area germanica) e quello di impronta romana, tipico dell’area mediterranea].
Ad esempio, la storia di molte comunità alpine insegna che i principali meccanismi di difesa in ambienti difficili erano costituiti dalla sostenibilità e dalla solidarietà, che si strutturavano in modelli di organizzazione sociale e in stili di vita capaci di fronteggiare le sfide di territori inospitali. Risposte a bisogni primari che contribuivano alla creazione di valori etici e sociali, di consuetudini, di istituti di diritto, di forme di gestione comunitaria dei territori e cooperativa dei beni comuni. A questo proposito, si possono citare esempi emblematici di istituzioni territoriali montane, originate in epoca medievale, che hanno mantenuto fino ai nostri giorni (aggiornandole ai tempi) le proprie peculiarità e funzioni: le magnifiche comunità (come quella di Fiemme, in Trentino) e le regole feudali.
Ma questi sono aspetti pre-giuridici, salvo che per i perduranti effetti di questi usi civici nella disciplina dell’impiego e del regime dei suoli, come è testimoniato nella recente vicenda sarda, che è sfociata nella sentenza della corte Costituzionale n. 103 del 2017. In essa si legge testualmente, tra l’altro, che: “nel contesto storico contemporaneo la rilevanza socio-economica delle antiche utilizzazioni si è notevolmente ridotta, ma le leggi più recenti hanno stabilito che i caratteri morfologici, le peculiari tipologie d’utilizzo dei beni d’uso civico ed il relativo regime giuridico sono meritevoli di tutela per la realizzazione di interessi generali, ulteriori e diversi rispetto a quelli che avevano favorito la conservazione integra e incontaminata di questi patrimoni collettivi”.
La teoria del bene comune si afferma quando si passa dall’aspetto statico a quello dinamico, quando cioè si guarda alla concreta destinazione di quel bene in favore dell’utilità di una cerchia allargata di persone.
Per un verso, la stessa Costituzione – quando all’articolo 42 disciplina la proprietà privata – si riferisce alla sua funzione sociale, cioè a una dimensione non strettamente ridotta al beneficio privato, ma anzi proiettata nelle dinamiche della più vasta produzione comune di valore.
Per altro verso, l’esperienza degli ultimi 30 anni ha portato a mettere in discussione la capacità dello Stato e degli enti pubblici di gestire con efficienza ed efficacia i beni di loro proprietà e di garantire che le finalità pubbliche siano davvero conseguite. Cittadini consapevoli e gruppi comunitari, protagonisti di esperienze di attivismo urbano, hanno spesso impugnato tematiche di comune interesse per rivendicare poteri e facoltà su beni o su processi.
Il caso del Teatro Valle è solo quello più noto ma pensiamo ai tanti spazi verdi, poco curati e esposti al degrado, nelle città.
Da questo punto di vista, il concetto di bene comune ha rappresentato uno strumento per contestare burocratismi, inefficienze e, qualche volta, persino corruzione, in omaggio a una vocazione e a un sentimento di condivisione comunitaria del valore dei beni, che ritroviamo anche nella Convenzione di Faro, in quel caso limitata ai beni culturali immateriali.
Sicché – come pure è stato già implicato qui stasera – il concetto di bene comune è stato storicamente un salutare scossone alla teoria dei beni e un fecondo sviluppo dell’idea di partecipazione democratica.
Nel caso di Faro l’impegno è a ratificarla quanto prima, concludendo il processo iniziato in senato. All’art. 1, lettera a), di quella convenzione le parti si impegnano a riconoscere il diritto al patrimonio culturale legato al diritto di partecipare alla vita culturale. In questo modo la dimensione patrimoniale fa il suo ingresso nella sfera dei diritti umani, arricchendola in modo significativo.
L’applicazione di queste nozioni alla cultura e ai beni culturali è – del resto – molto suggestiva, persino calzante.
L’espressione che l’articolo 9 della Costituzione adopera (“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”) sicuramente allude a un aspetto dinamico, di progresso e di valorizzazione, e non solo a quello statico della titolarità, cui si annette l’aspetto della tutela del patrimonio, che pure è previsto nel secondo comma dell’art. 9.
Peraltro, persino l’aspetto della tutela trova nella teoria del bene comune maggiore cittadinanza, dal momento che spesso sentiamo parlare di abbandono e degrado di parti del nostro patrimonio da parte di enti pubblici inefficienti o, forse più spesso, dotati di risorse insufficienti.
Quante volte abbiamo sentito parlare di siti abbandonati, non adeguatamente valorizzati, di incuria e di vandalismo, cui le autorità pubbliche non reagiscono a dovere?
Come primo approdo di riflessione, dunque, credo che potremmo concordare sul fatto che la teoria dei beni comuni – nel campo del patrimonio culturale – è uno stimolo importante.
Tuttavia, una volta metabolizzato questo stimolo e compresa l’importanza di non perdere di vista, da un lato, l’effettiva destinazione al pubblico beneficio dei beni culturali, dall’altro di non sottovalutare il moto civico che spesso reca la critica alle modalità di gestione, resta sul tappeto il problema delle risorse.
È chiaro, infatti, che manutenzione, conservazione, fruizione e promozione dei beni culturali richiedono sia investimenti, sia spesa corrente.
A chi andiamo a chiedere queste risorse?
Necessariamente, alle casse pubbliche. Aggiungo che questo non è solo necessario, ma anche giusto, se si tratta di beni culturali pubblici, e la maggior parte dei siti di interesse culturale lo è. Se, invece, il bene è privato, pur se gravato da un qualche vincolo, occuparsi di manutenzione e restauro spetta al proprietario privato, né potrebbe essere altrimenti.
Allora, ecco che l’apparato concettuale dei beni comuni torna sullo sfondo e, dal punto di vista giuridico, è gioco forza che si parli di nuovo di beni pubblici o privati, proprio perché l’angolo visuale da cui muove la teoria dei commons non coglie gli aspetti della responsabilità degli oneri.
Anche la felice intuizione della cosiddetta “rigenerazione urbana”, a opera di associazioni e comitati di cittadinanza attiva, deve contare su risorse certe. Sicché – per quanto motivata in modo radicato nella filosofia dei commons – tutta la riflessione sul recupero urbano e sulla gentryfication non può prescindere dal tema delle risorse, che siano fondi pubblici o donazione private.
Una seconda tappa del nostro ragionamento può quindi essere questa: a proposito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la teoria dei beni comuni non sembra in grado di modificare le categorie giuridiche e legislative delle politiche di spesa.
Si può però provare a spostare lo sguardo su una realtà limitrofa, che è quella costituita dalle imprese culturali e dalla connessa produzione di valore culturale.
Sotto questo profilo, tutti i ragionamenti relativi alla capacità della cultura di generare valore, di creare comunità e identità, possono riacquistare un ruolo.
Da tale punto di vista, mi pare rilevante citarvi due esempi, il primo costituito dal progetto di legge Ascani sulle imprese culturali e creative, che nella scorsa legislatura ha impegnato a lungo la Commissione cultura della Camera.
Già sul piano definitorio, identificare queste imprese non è stato semplice, proprio perché non si parte dalla proprietà dei beni, ma dalla funzione e dall’attività che gli imprenditori intendono svolgere in relazione ad essi.
Non posso dar conto dell’ampia mole di audizioni e del lavoro svolto, ma posso dirvi che, da ultimo, nella legge di bilancio per il 2018 quel disegno di legge ha trovato un parziale sbocco, con l’introduzione della definizione di impresa culturale e creativa, prima inesistente nell’ordinamento, peraltro riferita anche al terzo settore. Vi rinvi0, al riguardo, ai commi 57 e 58 dell’articolo unico della legge.
In via conclusiva, vorrei sottolineare che il credito d’imposta concesso a questo tipo di imprese costituisce un riconoscimento anche alla capacità che esse esprimono di creare un valore culturale diffuso, che contribuisce a sua volta alla crescita della comunità, rispondendo in tal modo ai richiami della teoria dei commons.
Ma proprio le difficoltà definitorie e di inquadramento, derivanti dall’aspetto dinamico svincolato dalla titolarità giuridica di beni culturali, hanno imposto di rimettere a un decreto ministeriale la concreta identificazione dei soggetti beneficiari e ci danno un esempio di ricaduta normativa del tema dei beni comuni e della sua complessità nella traduzione legislativa.
Il secondo esempio, cui facevo riferimento, è costituito dalla persistente problematica del diritto d’autore, nell’ambito del quale si fronteggiano, da un lato, l’ineludibile bisogno dell’autore di un prodotto culturale o artistico di essere remunerato per il proprio lavoro, e quindi di controllare l’accesso alla fruizione di esso; dall’altro, la convinzione diffusa che talune opere, elaborazioni intellettuali e creazioni lato sensu artistiche, nel mondo globalizzato e sempre più “connesso”, siano di per sé beni comuni, cui occorre garantire l’accesso più ampio e immediato possibile, secondo un’ottica di open data e di banda larga.
Per concludere davvero, mi è particolarmente caro citarvi l’ultima tappa della Commissione cultura nella scorsa legislatura, costituita da un’indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.
Pur nella varietà ed eterogeneità delle esperienze censite (festival della lettura, gestione di teatri e biblioteche da parti di enti locali, rassegne di danza e arte contemporanea, land-art, biennali in giro per il Paese), è emerso quale tratto largamente comune che la produzione culturale è di per sé un bene comune e, come tale, crea comunità e contribuisce al benessere di tutti.
Grazie per la vostra attenzione.