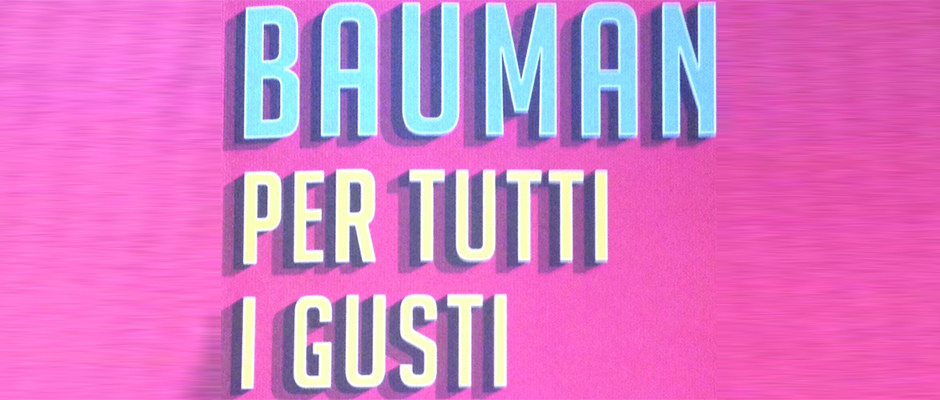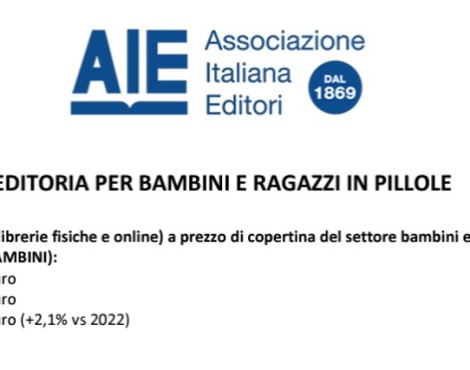Il mese scorso è stato pubblicato il saggio di Zygmunt Bauman Per tutti i gusti. La cultura nell’età dei consumi, edito da Laterza (pagg. 154, euro 14). Il titolo originale del volume è Culture in a Liquid Modern World e la prima pubblicazione risale al 2011, presso Polity Press Ltd, Cambridge.
Il libro, che si inserisce a pieno titolo, nella sua storica analisi e nei temi cari al sociologo polacco – sia per ciò che concerne la trasformazione della società, sia perché in parte riprende il discorso del suo saggio di vent’anni fa “La decadenza degli intellettuali” – è diviso in 6 capitoli: “La cultura. Storia del concetto”; “Moda, identità liquida e utopia per il presente: alcune tendenze culturali nel ventunesimo secolo”; “La cultura dalla costruzione della nazione alla globalizzazione”; “La cultura in un mondo di diaspore”; “La cultura in un’Europa che si unisce” e “La cultura tra Stato e mercato”.
La tesi fondamentale del saggio è che non esiste più un’élite culturale ma consumatori onnivori e che, addirittura, lo snobismo culturale oggi consiste nel non esserlo affatto quando si tratta appunto di consumi culturali. “Il segno distintivo che connota l’appartenenza a una élite culturale sono oggi un massimo di tolleranza e un minimo di schizzinosità” scrive Bauman. E aggiunge: “Il principio dell’elitarismo culturale sta nella sua capacità di sentirsi a proprio agio in qualunque ambiente culturale senza considerarne nessuno come casa propria, e ancor meno l’unica casa propria”.
L’offerta culturale si è moltiplicata e variegata. Questo, in sé potrebbe essere un aspetto positivo che tende ad abbattere le classi sociali dacché, citando Pierre Bordieu, Bauman ricorda che un tempo “c’erano gusti dell’élite culturale alta per natura; gusti medi o conformisti, tipici della classe media, e gusti volgari, adorati dalle classi inferiori, e mescolarli tra loro era difficile come mescolare fuoco e acqua”.
Ma questo mescolarsi (“collegarsi e scollegarsi” a reti diverse, per usare termini cari a Bauman e referenti proprio alla nostra società) e aver liberato l’arte dalla funzione gravosa che le era assegnata in passato, ha creato una distanza, spesso ironica o cinica, nei suoi confronti sia da parte dei suoi creatori come da quella dei suoi destinatari. “L’arte, quando se ne parla, – continua Bauman – raramente ispira quel tono devoto o reverenziale così comune nel passato. Non ci si azzuffa. Non si erigono barricate. Niente scintillare di lame. Se pure si discute della superiorità di una forma d’arte su un’altra, se ne parla senza passione o verve; e i proclami di condanna e le diffamazioni sono più rari di quanto fossero mai stati prima”.
Per Bauman dietro questo stato di cose si nascondono imbarazzo, mancanza di fiducia in se stessi e senso di disorientamento: se gli artisti non hanno grandi e importanti compiti da realizzare, se le loro creazioni non hanno altro scopo che portare fama e fortuna a pochi eletti e divertimento e piacere personale ai loro beneficiari, come possiamo giudicarli se non attraverso la montatura pubblica che di solito li accompagna in un determinato momento?
È proprio dell’economia liquido-moderna, orientata al consumo, basarsi su un surplus di offerte, sul loro rapido deperimento e sul prematuro appassimento dei loro poteri di seduzione. Diventa quindi essenziale fornire ininterrottamente nuove offerte per alimentare un più rapido avvicendamento di beni, con un intervallo di tempo sempre più breve tra il loro acquisto e il loro abbandono, seguito dalla sostituzione con beni “nuovi e migliori”. Ed è ancora “essenziale” al fine di evitare una situazione in cui un’ulteriore delusione verso specifici beni, si trasformi in una delusione generale verso una vita intessuta e ricamata col filo del fervore consumistico sulla tela delle reti commerciali.
La cultura assomiglia oggi, per il semiologo polacco, a un reparto di un grande magazzino, in cui si aggirano persone trasformate in puri e semplici consumatori.
E pare dunque ovvio che nella nostra modernità liquida la cultura non ha più un “volgo” da illuminare ed elevare ma clienti da sedurre. E se un tempo, la funzione della cultura era soddisfare bisogni esistenti, oggi pare essere quella di crearne sempre di nuovi.
La cultura. Storia del concetto
In questo capitolo Bauman tesse un breve exursus della parabola culturale. La cultura era una forza conservatrice: doveva essere enfatica e fornire etichette (bello, brutto). Poi ha assunto valore di agente di cambiamento e non di conservazione dello status quo e il suo scopo divenne educare le masse e raffinare i costumi per far progredire la società. Da qui, pure certo colonialismo inteso come missione “dell’uomo bianco” di civilizzazione. All’interno dello Stato invece passò da stimolante a tranquillante, fino all’oggi, in cui la cultura è costituita da offerte, non da proibizioni, destinata “a seminare e piantare bisogni e desideri piuttosto che a imporre doveri”.
Moda, identità liquida e utopia per il presente: alcune tendenze culturali nel ventunesimo secolo
Afferma Georg Simmel che la moda “è una particolare forma di vita che cerca di garantire un compromesso fra la tendenza all’eguaglianza sociale e la tendenza alla separatezza individuale”. E il progresso, secondo l’analisi di Bauman, è diventato uno sforzo disperato di non uscire di pista piuttosto che un miglioramento di vita. Dal moto perpetuo della moda e all’idea così intesa di progresso non resta esclusa, anzi, la cultura che richiede da noi cambiamenti “pari a quelli che riserviamo ai calzini o alle camicie”.
La cultura dalla costruzione della nazione alla globalizzazione
In questo capitolo Bauman analizza la storia della migrazione moderna. La prima (circa 60 milioni di persone) dall’Europa alle “terre vuote” con il corredo di “civilizzazione” e cultura; la seconda quella al contrario, ovvero dei colonizzati che seguirono i colonizzatori nel ritorno in patria e che diedero vita alle cosiddette minoranze da assimilare; la terza, ancora in pieno svolgimento, cosiddetta delle diaspore che “mette in questione l’incipiente e indistruttibile legame tra identità e nazionalità”. Le relazioni culturali non sono più verticali ma orizzontali e nascono così dispute infinite sul diritto ad essere diversi. La filosofia del multiculturalismo poi, che Bauman asserisce essere ormai di moda tra “i modernisti senza modernismo”, smentisce il valore da essa stessa propagandato sul piano teorico, cioè l’armoniosa (conviviale?) coesistenza delle culture. “Consciamente o involontariamente (…) questa filosofia sostiene tendenze separatistiche e quindi antagonistiche, rendendo così ancora più difficile qualsiasi tentativo di un serio dialogo multiculturale”. E il multiculturalismo è diventata la risposta più “comoda” per gli intellettuali riguardo la forma preferibile per la condizione umana, ritenendo il multiculturalismo “l’ideologia della fine dell’ideologia” .
La cultura in un mondo di diaspore
Le classi colte di età moderna (il concetto di “intellettuale” è figlio del ventesimo secolo) avevano il compito di ri-piantare, coltivare (termini equipollenti al bildung in tedesco e refinement in inglese) ciò che era stato sradicato. In Francia con l’Illuminismo, si aprì la strada all’uomo nuovo (che doveva esser privato di credenze e superstizioni) e da qui la riforma anche dell’istruzione e in campo sociale. Ma la cultura veniva identificata anche nella sua essenza con l’europeizzazione. Lo Stato moderno richiedeva insegnanti, supervisori, e dirigenti. Bauman sostiene che oggi stiamo entrando nell’epoca del disimpegno e che la distanza è divenuta la principale strategia del potere che ha le caratteristiche del Dio del Medioveo: lontano dagli uomini che quindi devono autodeterminarsi senza indirizzo e che diventano quindi una sorte di sciame in balia di chi determina il consumo culturale. La società: “ha presto desistito dal comandare le scelte degli uomini e dall’amministrare le loro azioni” permettendogli di creare le proprie preferenze. E tuttavia sarebbe compito degli intellettuali il riconoscimento dei valori e la scelta culturale. Spesso per gli Stati la scelta culturale diviene scelta politica (e qui si pone l’esempio del Québec che ha imposto lo studio della lingua francese oltre che dell’inglese a scuola). Le repubbliche costituzionali dovrebbero insomma conciliare i diritti di una comunità e i diritti dei singoli cittadini. La situazione si complica in presenza di comunità straniere. Bauman differenzia il concetto di multiculturalismo da quello di multicomunitarismo, sostenendo che l’integrazione è possibile solo laddove la cultura della singola comunità sia rispettata.
La cultura in un’Europa che si unisce
Per Bauman “sotto la pressione della globalizzazione le nazioni europee si stanno trasformando da enti territorialmente coesi in associazioni di unità spiritualmente alleate sempre più mobili e spazialmente disperse”. Con la globalizzazione il potere diviene extraterritoriale mentre le istituzioni politiche rimangono localizzate. L’indebolimento dello Stato-nazione che deriva, porta alla deregulation. “La mobilitazione ideologico-culturale dei cittadini – un tempo strumento essenziale attraverso il quale lo Stato accumulava
autorità e potere – è divenuta superflua (…) le autorità statali non sovraintendono più ai processi di integrazione sociale o di amministrazione del sistema, ossia i compiti per i quali in passato erano indispensabili la regolamentazione normativa, la gestione della cultura e la mobilitazione del sentimento patriottico”. In tale contesto solo gli spiriti liberi, più acculturati e indipendenti, riescono a non soggiacere alla politica culturale dei consumi. Ma è nella cultura che per Bauman risiede il vero collante europeo. La cultura deve esser difesa su due fronti: “da una parte contro le crociate culturali e l’omogeneizzazione oppressiva; dall’altra contro l’indifferenza prepotente e sen’anima del disimpegno” che è caratteristica sempre più marcata di cittadini e intellettuali.
La cultura tra Stato e mercato
Ricorda Bauman come in Francia il coinvolgimento dello Stato nelle arti sia iniziato prima che in altri Paesi (nel XVI secolo con Francesco I). Lo stesso termine di cultura sorse per indicare gli sforzi del governo per promuovere il sapere. Questa missione, con ovvie differenze, è passata anche alle successive forme di governo (dalla Comune in poi). Verso la fine dell’800 si impose il concetto di “patrimoine”, eredità nazionale di cui prendersi cura per i cittadini, considerato identità nazionale, unità nazionale e civica in generale. Nel 1959 viene istituito da De Gaulle il ministero degli Affari Culturali. E da allora, come sottolinea François Chabot, non sono mai venute a mancare le risorse a questo ministero perché attraverso la cultura doveva propagarsi nel mondo la gloria e l’autorevolezza francese. Inoltre lo Stato francese non mai hai fatto scelte culturali precise ma le ha sostenute tutte in generale, cosa che di recente ha attirato il sarcasmo di Marc Fumaroli. È inevitabile che si venga a creare disaccordo tra chi fa arte e chi l’amministra anche se i pensatori citati da Bauman sostengono che le due categorie siano a volte come marito e moglie, altre come fratelli o abitanti lo stesso condominio. Le autorità statali che hanno abbandonato la gestione diretta della cultura hanno aperto la strada a quelli che Bauman definisce “i manager della cultura” che hanno spostato l’asse totalmente sul consumo culturale. Bauman arriva scrivere che: “sottoporre l’attività culturale ai parametri del mercato dei consumi equivale a richiedere che le opere d’arte accettino le condizioni di ingresso fissate per ogni prodotto che aspiri al rango di genere di consumo ossia che si giustifichi nei termini del valore di mercato”. In tale contesto la domanda finale che si pone Bauman è dunque: “Può la cultura sopravvivere alla svalutazione dell’essere e alla caduta dell’eternità?”