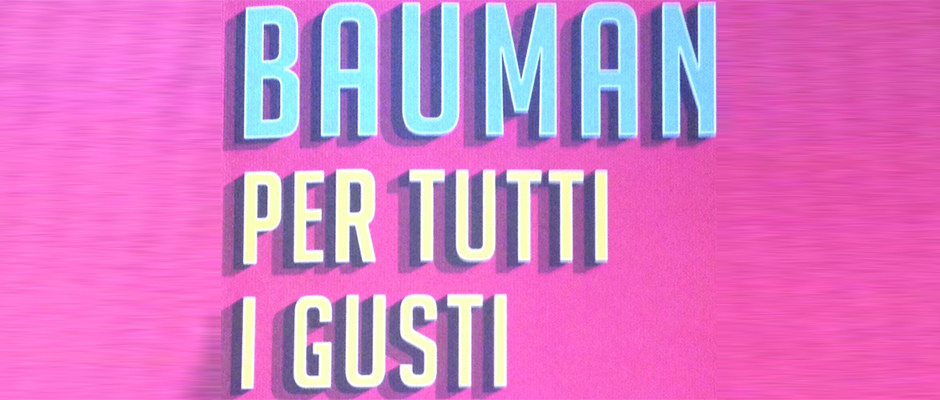Elena Lucrezia Corner Piscopia: la prima laureata italiana. Di cui pochi conoscono la storia, raccontata dallo scrittore Alessandro Marzo Magno in un monologo interpretato dall’attrice triestina Zita Fusco.
Lucrezia si laurea all’Università di Padova il 25 giugno 1678, a trentadue anni. Laurea in Filosofia, concessa con una decina di anni di ritardo perché un uomo le mette i bastoni di traverso. Impedendole, tra l’altro, di conseguire il titolo in Teologia perché la Chiesa è persuasa dell’inferiorità della donna, «incapace di ragionamenti difficili». A diciannove anni Lucrezia diventa oblata benedettina, e quindi rispetta i voti delle monache (vivendo però nel comodo e lussuoso palazzo di famiglia). L’uomo che si mette di traverso si chiama Gregorio Barbarigo: vescovo di Padova e cancelliere dell’università, cardinale, diventerà santo durante il pontificato di Giovanni XXIII. Se Lucrezia avesse vissuto ai nostri tempi si sarebbe potuta laureare anche in Lingue antiche, e persino in Lingue moderne: conosceva il greco, il latino, l’ebraico (lo aveva studiato sotto la guida del rabbino di Venezia), il francese, l’inglese e lo spagnolo. E forse si sarebbe pure meritata una laurea in Matematica.
(fonte Io Donna, 8 marzo 2016)